E niente. Glielo devo, a Giuseppe.
Non so proprio cosa scrivere. Forse la cosa migliore è cominciare dall’inizio. Ci provo.
Non è la prima volta che muore un mio studente. In ventiquattro anni di insegnamento, a botte di circa tre, quattrocento studenti l’anno, non è così improbabile avere a che fare con tragedie del genere.
(Senza contare la morte di colleghi, o la morte dei genitori dei miei allievi. Ma la morte di un ragazzo, beh, è molto più difficile da accettare.)
Negli ultimi anni, per dire, sono morti due miei ex allievi.
Uno al primo anno di università. A un incrocio con la statale 45. Non so se avesse torto o ragione, chissenefrega, fatto sta che bum, c’è rimasto secco sul colpo. Vent’anni, brillante, matricola a ingegneria dei trasporti, se ricordo bene, ma non importa. Quanti dei miei studenti sono rimasti coinvolti in incidenti, quanti ne sono morti? Non so, certo non una moltitudine, ma nemmeno pochi. Gli incidenti, si sa. Càpitano.
L’altro, alle soglie della laurea. La puntura di un’ape, di una vespa, vallo a sapere. Mentre stava andando a casa in motorino, lui che abitava in campagna. Ha fatto a tempo ad arrivare, a togliersi il casco e a dire che stava male. Poi, buio. Shock anafilattico. Che è già diverso da un incidente d’auto, eh. Il fattore sfiga assume dimensioni più mostruose, e tutto cospira per farti bestemmiare come se non ci fosse altro mezzo per dare sfogo al dolore. Ma si sa, son cose che capitano. Raramente, eh, grazie al cielo, ma capitano.
Ma Giuseppe no. È tutta un’altra storia. E non me ne capacito, non mi do pace.
Giuseppe ce l’ho avuto per un solo anno. Ma era l’anno della mia unica supplenza annuale di storia e filo. Così, con la classe di Giuseppe ho trascorso più tempo di quanto non ne trascorra normalmente in cinque anni con le classi in cui insegno religione. A quei ragazzi mi sentivo e mi sento tuttora legato.
Fatto sta che Giuseppe era un mio allievo. Bravo, capace. Timido, mai sopra le righe, ma di compagnia, spiritoso e sveglio.
L’ultimo ricordo che ho di lui è una sua mail che mi ha scritto all’indomani della terza prova d’esame, con una sua battuta e i ringraziamenti per il messaggio di auguri che avevo spedito loro la sera prima.
Giuseppe ha studiato a Pavia e si è laureato in biotecnologie, naturalmente in corso.
Giuseppe ha compiuto ventitre anni il 21 agosto.
E una settimana dopo, la sera, Giuseppe si è buttato sotto a un treno nella stazione di Pavia.
Perché.
Perché, perché. Perché.
Boh.
Io l’ho saputo solo ieri sera. Mentre partecipavo all’asta di un fantacalcio. Perché è giusto che la vita ci prenda per il culo, è giusto così. Me l’ha detto un suo ex compagno di classe.
Era un po’ di tempo che Giuseppe aveva dei disturbi, mi ha raccontato. Niente di grosso, delle amnesie, ma insomma, la cosa lo aveva preoccupato. E ha provato, come è ovvio, a guardarci dentro.
Ma a quel che ho capito, non ha nemmeno aspettato di avere in mano l’esito delle analisi. Ha lasciato un messaggio, credo sul telefonino, e il senso del messaggio era: preferisco aver vissuto pienamente anche solo ventitre anni piuttosto che vivere da larva il tempo che mi rimane.
Il telefonino lo ha abbandonato, o gettato, sulla banchina della stazione di Pavia.
Su Facebook ci sono i messaggi dei suoi amici, come sempre in queste occasioni. Sono tutti improntati a grande tristezza, com’è ovvio, ma anche a grande pace. Sembrano tutti comunque contenti di averlo conosciuto, di avere avuto a che fare con lui (giuro, li capisco, e credo che siano sinceri, ché il ricordo che ho di Giuseppe mi porterebbe a dire le stesse cose).
Poi ci sono i suoi ultimi messaggi. Giuseppe che ringrazia gli amici per la festa di compleanno a sorpresa. Giuseppe che posta il video delle canzoni di un paio di gruppi a me ignoti. Giuseppe che non si ricorda di aver spostato in un’altra cartella i filmati della sua vacanza, e che la trova vuota. Una delle sue amnesie, forse. Fatto sta che ventiquattr’ore dopo si buttava sotto a un treno.
La sorella dice che non lo perdonerà mai. Che questo non glielo doveva fare. Che certo, continuerà a volergli bene, ma non doveva farli soffrire così.
E insomma, tutto il luna park del dolore, tanto scontato quanto inevitabile e vero.
E io non so cosa dire. Al solito mi vien da pensare a un bel po’ di cose, forse banali, ma non so che farci.
Tipo.
Ma porca puttana, con 603 contatti su Facebook, neanche un cane con cui provare a parlare a tu per tu, con cui sfogarti, a cui dire che non ne potevi più?! Perché sempre questa sorpresa, questo dire ma non sembrava, nessuno se l’aspettava?
E davvero non sembrava? Chissà quanti segnali avrai dato, chissà quante parole buttate lì, quanti discorsi appena abbozzati. Chissà quanti momenti in cui sei stato insieme a qualcuno ma senza che nessuno fosse davvero presente, lì, per l’altro. Disposto davvero a guardare l’altro, disposto davvero all’ascolto. Chissà quanto dolore ci passa accanto, anche in chi ci è più vicino, e noi manco ce ne accorgiamo.
E di cosa hai avuto paura, Giuseppe? Non di morire, è evidente. E nemmeno del dolore. Non hai fatto una morte meno dolorosa di quella che (forse!) ti era destinata. E allora, di cosa hai avuto paura?
Ahimè, di vivere. Non mi viene altra risposta. Di vivere a condizioni diverse da quelle che tu volevi porre.
Ne avevi diritto? Sei stato vigliacco? Sei stato coraggioso? Ti sei sentito solo? Abbandonato?
La cosa tremenda è che né io, né nessuna delle persone che tu hai incontrato in ventitre anni è stata in grado di lasciarti qualcosa che, in quel momento, fosse in grado di fermarti, di farti cambiare idea.
È per questo che sono triste. Che scrivo questo post orrendo. Per l’inutilità e lo spreco della tua morte. Per l’inutilità e lo spreco dei rapporti. L’inutilità e lo spreco del tempo, di quel che dico e che faccio.
Perdonami. Perdonaci.
La rottura tra Gregorio VII ed Enrico IV non fu immediatamente successiva al decreto sulle investiture: solo che il re mostrò di non tenerne conto, inviando in Lombardia uno dei suoi fedeli, il conte Everardo, che, radunata una dieta a Roncaglia, fece eleggere Tedaldo, suddiacono milanese e cappellano del re, nuovo arcivescovo di Milano – nonostante ancora vivesse il candidato della pataria, già approvato dalla sede apostolica – e investendo negli stessi mesi dei vescovadi di Fermo e Spoleto, rimasti vacanti, due persone a lui fedeli e sconosciute al papa. Si trattava del rafforzamento e dell’estensione anche all’Italia di quella politica ecclesiastica che si connetteva intimamente per Enrico al problema del rafforzamento della compagine del regno. Alle proteste di Gregorio VII e alle minacce di scomunica e di deposizione, Enrico rispose nel gennaio 1076 con le assemblee di Worms e di Piacenza, dove gli episcopati rispettivamente tedesco e lombardo decretarono la deposizione di Gregorio VII. La replica di Gregorio fu nel concilio romano del febbraio la deposizione di Enrico, la sua scomunica e lo scioglimento dei sudditi dal giuramento di fedeltà.

 Se ho sentito la tua mancanza, mi chiedi?
Se ho sentito la tua mancanza, mi chiedi? L’idea della presenza di Dio tra i combattenti per la propria città si manifesta talvolta anche nei moduli narrativi usati per salutare i successi della propria parte. Nell’aprile 1175 Federico Barbarossa cerca di conquistare Alessandria, irriducibile al duro assedio, facendo scavare una galleria che passando sotto le mura avrebbe dovuto sboccare nel mezzo della città; aveva dato assicurazione che avrebbe rispettato la Pasqua e invece proprio la mattina della santa domenica egli attaccò battaglia: «Ma Dio combatté per i cittadini, e tutti coloro che si trovavano nella galleria e sulla torre di legno… morirono, e la torre fu bruciata». Nel giugno 1215 gli Annales placentini registrano il fallimento di una spedizione cremonese contro la loro città «divina potentia et civium Placentiae protectione», come nel luglio dello stesso anno un’altra incursione cremonese fallisce «divina misericordia et virtute atque auxilio militum et sagittariorum».
L’idea della presenza di Dio tra i combattenti per la propria città si manifesta talvolta anche nei moduli narrativi usati per salutare i successi della propria parte. Nell’aprile 1175 Federico Barbarossa cerca di conquistare Alessandria, irriducibile al duro assedio, facendo scavare una galleria che passando sotto le mura avrebbe dovuto sboccare nel mezzo della città; aveva dato assicurazione che avrebbe rispettato la Pasqua e invece proprio la mattina della santa domenica egli attaccò battaglia: «Ma Dio combatté per i cittadini, e tutti coloro che si trovavano nella galleria e sulla torre di legno… morirono, e la torre fu bruciata». Nel giugno 1215 gli Annales placentini registrano il fallimento di una spedizione cremonese contro la loro città «divina potentia et civium Placentiae protectione», come nel luglio dello stesso anno un’altra incursione cremonese fallisce «divina misericordia et virtute atque auxilio militum et sagittariorum». Un’altra complicazione, nella lotta di classe del primo Duecento, fu la frequente presenza di nobili nella direzione del movimento di popolo. Ma ciò era avvenuto già nel secolo XI a Milano, al tempo di Lanzone, capitaneus in guerra contro i capitanei, e significava soltanto la necessità per la popolazione non nobile, nel corso della lotta, di scegliere capi dal ceto militarmente più esperto, sfruttandone le discordie interne. Del resto il contrasto fra le fazioni nobiliari, in gara per il predominio politico, non poteva non intrecciarsi con il conflitto di classe: che esprimeva una tensione sociale, ma si poneva anch’esso su un piano schiettamente politico. Ciò anzitutto in quanto l’opposizione alla classe dei nobili era alimentata dall’esigenza di porre un freno alla violenza appunto, con cui le consorterie contendevano per conseguire il potere nell’organismo comunale: basti pensare agli anni di guerriglia, di barricate, di incendi che afflissero Firenze dal 1177 al 1179, quando la consorteria degli Uberti insorse contro la lunga prevalenza della coalizione capeggiata dai Donati. D’altra parte, questa volontà popolare di presenza politica, intesa a costringere i nobili a metodi nuovi nella lotta per il potere, si complicò normalmente con una precisa richiesta di partecipazione effettiva al governo cittadino e di spartizione equilibrata delle cariche comunali, e si tradusse talvolta in una integrale, pur se ancora provvisoria, conquista dell’organismo comunale da parte del popolo: come avvenne a Piacenza nel 1220, quando i milites abbandonarono la città, tornandovi più di un anno dopo per l’intervento pacificatore di un legato papale.
Un’altra complicazione, nella lotta di classe del primo Duecento, fu la frequente presenza di nobili nella direzione del movimento di popolo. Ma ciò era avvenuto già nel secolo XI a Milano, al tempo di Lanzone, capitaneus in guerra contro i capitanei, e significava soltanto la necessità per la popolazione non nobile, nel corso della lotta, di scegliere capi dal ceto militarmente più esperto, sfruttandone le discordie interne. Del resto il contrasto fra le fazioni nobiliari, in gara per il predominio politico, non poteva non intrecciarsi con il conflitto di classe: che esprimeva una tensione sociale, ma si poneva anch’esso su un piano schiettamente politico. Ciò anzitutto in quanto l’opposizione alla classe dei nobili era alimentata dall’esigenza di porre un freno alla violenza appunto, con cui le consorterie contendevano per conseguire il potere nell’organismo comunale: basti pensare agli anni di guerriglia, di barricate, di incendi che afflissero Firenze dal 1177 al 1179, quando la consorteria degli Uberti insorse contro la lunga prevalenza della coalizione capeggiata dai Donati. D’altra parte, questa volontà popolare di presenza politica, intesa a costringere i nobili a metodi nuovi nella lotta per il potere, si complicò normalmente con una precisa richiesta di partecipazione effettiva al governo cittadino e di spartizione equilibrata delle cariche comunali, e si tradusse talvolta in una integrale, pur se ancora provvisoria, conquista dell’organismo comunale da parte del popolo: come avvenne a Piacenza nel 1220, quando i milites abbandonarono la città, tornandovi più di un anno dopo per l’intervento pacificatore di un legato papale. Le attività della commissione insediata a Ravenna sotto la direzione dell’arcivescovo del luogo, Rinaldo da Concorezzo, sono ben note. Istituita nel settembre 1309, essa sovrintende alle inchieste diocesane. Poi, conformemente alle direttive della bolla Faciens misericordiam, è riunito un concilio provinciale; tiene due sessioni, nel gennaio e nel giugno 1311, nel corso delle quali sono esaminati i verbali. I templari di Piacenza, Bologna, Faenza compaiono ancora un’ultima volta. Sono dichiarati innocenti anche dall’inquisitore francescano; solo i due inquisitori domenicani criticano l’arcivescovo e rifiutano la sentenza. Si rivolgono al papa, che ordina all’arcivescovo di riprendere l’inchiesta, rimproverandolo di non aver applicato la tortura. Rinaldo da Concorezzo, che non riconosce la validità delle confessioni ottenute sotto tortura, rifiuta e chiude la vicenda. I suoi colleghi di Pisa e di Firenze non hanno avuto la stessa fermezza e hanno ripreso gli interrogatori ricorrendo alla tortura. A Venezia l’Inquisizione è nelle mani del doge. I templari sono lasciati tranquilli e possono rimanere nella loro casa.
Le attività della commissione insediata a Ravenna sotto la direzione dell’arcivescovo del luogo, Rinaldo da Concorezzo, sono ben note. Istituita nel settembre 1309, essa sovrintende alle inchieste diocesane. Poi, conformemente alle direttive della bolla Faciens misericordiam, è riunito un concilio provinciale; tiene due sessioni, nel gennaio e nel giugno 1311, nel corso delle quali sono esaminati i verbali. I templari di Piacenza, Bologna, Faenza compaiono ancora un’ultima volta. Sono dichiarati innocenti anche dall’inquisitore francescano; solo i due inquisitori domenicani criticano l’arcivescovo e rifiutano la sentenza. Si rivolgono al papa, che ordina all’arcivescovo di riprendere l’inchiesta, rimproverandolo di non aver applicato la tortura. Rinaldo da Concorezzo, che non riconosce la validità delle confessioni ottenute sotto tortura, rifiuta e chiude la vicenda. I suoi colleghi di Pisa e di Firenze non hanno avuto la stessa fermezza e hanno ripreso gli interrogatori ricorrendo alla tortura. A Venezia l’Inquisizione è nelle mani del doge. I templari sono lasciati tranquilli e possono rimanere nella loro casa.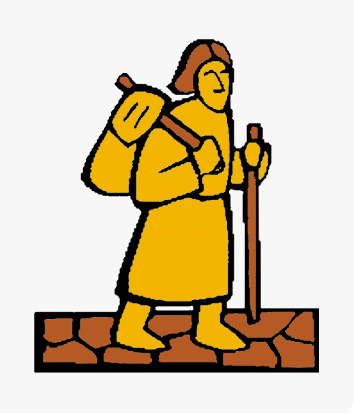 Gli storici italiani hanno posto l’accento sull’importanza delle grandi vie, d’origine romana per lo più, che attraversano l’Italia, in particolare la Via Francigena che, attraverso le Alpi, unisce la Francia a Roma – via che i documenti di allora definiscono come «la via comunemente percorsa dai pellegrini e dai mercanti». Dalla Francia la strada prende due itinerari, uno attraverso la Svizzera e il Gran San Bernardo, l’altro attraverso Lione e il Moncenisio. Il primo passa per Aosta, Ivrea, Vercelli, Piacenza, tutte città in cui fin dall’inizio sono stati costruiti complessi templari. La seconda passa per Susa, Torino, Chieri, Asti eccetera. Anche in questo caso sono fondate case di templari, specialmente a Chieri, importante crocevia stradale. I due itinerari si riuniscono in Toscana e le città di Lucca, Firenze, San Gimignano, Siena, Grosseto sono sede di importanti commende templari. Significativamente, alcune di queste case sono costruite fuori le mura, vicino a Siena (Porta Camollia), a Lucca (Porta San Donato), a Pavia (Porta Santa Giustina). A Brescia fuori le mura, nel vicolo della Mansione (casa del Tempio), si trova la chiesa di Santa Maria del Tempio. Inoltre, ad alcune di queste case furono uniti ospedali: è il caso di quello che il vescovo di Torino Arduino di Valperga ha donato ai templari, vicino al ponte di Testora, con l’incarico di ricostruire il ponte. A Piacenza, oltre alla casa legata alla chiesa Santa Maria, il Tempio ha a sua disposizione l’ospedale della Misericordia, unito alla chiesa di Sant’Egidio.
Gli storici italiani hanno posto l’accento sull’importanza delle grandi vie, d’origine romana per lo più, che attraversano l’Italia, in particolare la Via Francigena che, attraverso le Alpi, unisce la Francia a Roma – via che i documenti di allora definiscono come «la via comunemente percorsa dai pellegrini e dai mercanti». Dalla Francia la strada prende due itinerari, uno attraverso la Svizzera e il Gran San Bernardo, l’altro attraverso Lione e il Moncenisio. Il primo passa per Aosta, Ivrea, Vercelli, Piacenza, tutte città in cui fin dall’inizio sono stati costruiti complessi templari. La seconda passa per Susa, Torino, Chieri, Asti eccetera. Anche in questo caso sono fondate case di templari, specialmente a Chieri, importante crocevia stradale. I due itinerari si riuniscono in Toscana e le città di Lucca, Firenze, San Gimignano, Siena, Grosseto sono sede di importanti commende templari. Significativamente, alcune di queste case sono costruite fuori le mura, vicino a Siena (Porta Camollia), a Lucca (Porta San Donato), a Pavia (Porta Santa Giustina). A Brescia fuori le mura, nel vicolo della Mansione (casa del Tempio), si trova la chiesa di Santa Maria del Tempio. Inoltre, ad alcune di queste case furono uniti ospedali: è il caso di quello che il vescovo di Torino Arduino di Valperga ha donato ai templari, vicino al ponte di Testora, con l’incarico di ricostruire il ponte. A Piacenza, oltre alla casa legata alla chiesa Santa Maria, il Tempio ha a sua disposizione l’ospedale della Misericordia, unito alla chiesa di Sant’Egidio.