Piacenza è dal 1995 la città italiana col maggior numero di testate studentesche. Dice l’articolo sul Corriere che ce ne sono 18 attive ininterrottamente da 30 anni.
Si potrà discutere sulla valenza educativa del giornalino d’istituto e sulla qualità delle singole testate e degli articoli pubblicati. So però che i ragazzi che ci lavorano dentro (una ventina per ogni redazione scolastica) ci mettono voglia, passione e tempo, e portano a casa una maggiore confidenza col testo stampato e la strana idea che si possa esprimere quel che si pensa, e, ancor prima, che si debba pensare qualcosa.
Ma la cosa straordinaria è quest’uomo, che segue da trent’anni il mondo dei giornali d’istituto piacentini, il prof. Schinardi, splendido settantacinquenne che io ricordo come insegnante di italiano e latino di mio fratello, all’epoca adolescente pseudorivoluzionario da salotto (ehm, ciao Vito) ma letteralmente invaghito di questo strano prof che in un’epoca di alternatività obbligatoria e di conformisti controcorrente riusciva a far amare la letteratura italiana a chi reclamava il sei politico. E adesso che è in pensione è ancora lì che non molla, che coordina, motiva, spinge e organizza. Ce ne fossero, ancora.
Gli obiettivi di apprendimento relativi alla scrittura in lingua italiana al termine della scuola primaria, come elencati dalle Indicazioni per il curricolo – 2007, non sono alla portata di un buon 50% degli utenti dei social network. E sono stato basso.
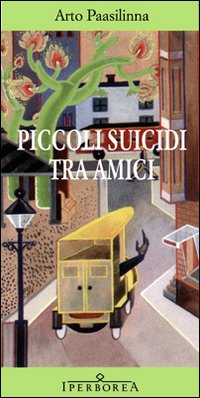
Paasilinna, Piccoli suicidi fra amici.
Ho imparato che per Paasilinna il suicidio è irragionevole, sempre. La vita è cambiamento, mutamento, variare di circostanze. L’attimo che viene può portare con sé occasioni e incontri che rendono meno rilevante quanto è accaduto prima. Perfino tentare il suicidio può rivelarsi fonte di cambiamento ed essere la circostanza attraverso la quale la vita cambia. Il suicidio è un’impennata della volontà, ha senso se hai deciso che sei tu che decidi. Ma è una decisione, appunto. E come per quelli che dicono oh, insomma, io la penso così, mica è detto che se lo pensi, se lo decidi, sia vero.
Paasilinna descrive una specie di TripAdvisor dei posti d’Europa dove è più figo suicidarsi, ammesso che lo si voglia fare in massa e in modo spettacolare, tipo lanciandosi nel vuoto dentro un pullman. Il must pare essere Capo Nord. A giudicare dalle foto c’è andato in vacanza mezzo Feisbuc. Coincidenze? Mah.
In subordine vanno fortissimo i burroni delle Alpi svizzere, ma anche l’Algarve non è male, in faccia all’Atlantico, alla Fortaleza de Sagres.
E poi ho imparato che Il portoghese deriva dal tardo latino, e il sami dal bramito delle renne.
Regio Decreto 1054 del 6 maggio 1923. Un pezzettino di riforma Gentile: si decide che presidi e professori vadano in pensione a 70 anni. L’aspettativa media di vita alla nascita era di 51,1 anni. ‘Na truffa. L’Inps doveva essere miliardario.





 E c’è sempre questa strana cosa, per la quale, quando finisco di leggere alcuni libri – e mi sembra che accada soprattutto coi libri -, sento di aver portato a termine un compito importante, di avere compiuto una piccola ma essenziale tappa della mia vita, di avere assolto ad un dovere che avesse a che fare
E c’è sempre questa strana cosa, per la quale, quando finisco di leggere alcuni libri – e mi sembra che accada soprattutto coi libri -, sento di aver portato a termine un compito importante, di avere compiuto una piccola ma essenziale tappa della mia vita, di avere assolto ad un dovere che avesse a che fare 
